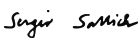Due libri usciti ora in Italia, le memorie del ragazzo che lo conobbe e l’indagine del grande musicologo d’oggi, ridisegnano la sua immagine. Una nuova libertà fra gli interpreti fa intuire le sue nuove parole di creatore.
Come avvicinare Beethoven, oltre che ascoltandone la musica? Certo, anche leggendo i libri che su di lui sono stati scritti, e prima di tutto i documenti della sua vita: le lettere, i quaderni di conversazione attraverso i quali la sordità lo costringeva a comunicare col mondo, i taccuini. Un materiale immenso, confuso, spesso lacunoso, ma di fortissimo impatto sia intellettuale che emotivo. E poi la bibliografia, non meno sterminata e varia, orientata nei modi più diversi, nella quale si rispecchiano i nostri mutamenti di gusto, di metodo, di interessi nei confronti di un autore avvolto nel mito ma sempre presente alla nostra coscienza. Come accade per l’interpretazione, dove un’esecuzione soltanto corretta, l’esecuzione di medio livello delle abitudini di ieri e di oggi, è, per Beethoven più che per altri, una cattiva esecuzione, così anche nell’indagine critica e storica ciò che conta e di cui non possiamo fare a meno è la restituzione di quella tensione di quella emozione, indefinibili fino in fondo ma intensissime sempre, che la biografia e le opere di Beethoven suscitano; e la chiave per entrare in quel monto di passioni e di idee è più importante della bussola grazie alla quale, alla fine, uscirne. Perché noi, in realtà, non vorremmo uscirne mai.
La pubblicazione quasi contemporanea delle traduzioni italiane di due libri assai diversi fra loro – Ludwig van Beethoven nei miei ricordi giovanili di Gerhard von Breuning (SE) e Beethoven e il suo tempo di Carl Dahlhaus (Edt) – può offrire lo spunto per qualche riflessione. E anzitutto conferma quanto molteplice sia l’immagine che ancora oggi possiamo farci anche di un autore di cui crederemmo di sapere già tutto, come Beethoven. Naturalmente la diversità dei due libri – l’uno scritto nel 1874 da chi ebbe occasione di frequentare di persona Beethoven, l’altro uscito nel 1987 come frutto del lavoro di ricerca di uno dei più arcigni e seriosi musicologi tedeschi – sta non soltanto nel contenuto, ma anche nel metodo. Ed è una diversità che possiamo prendere come punto di riferimento per un approccio biografico da un lato, critico-scientifico dall’altro: in entrambi i casi, di alto profilo.
Che contributo ne riceviamo alla nostra conoscenza di Beethoven? Leggendo i ricordi di Breuning ci troviamo immersi di colpo in un mare tumultuoso di notizie, aneddoti, osservazioni, commenti, digressioni e via dicendo, che posseggono intatto un loro fascino arcano, quasi fiabesco, e che sembrano trasportarci come all’interno stesso della vita quotidiana di Beethoven: facendoci partecipi dei suoi drammi, grandi e piccoli, e delle sue occupazioni, grandi e piccole. Il libro di Dahlhaus è invece di tutt’altra specie: rigoroso, concettuale, analitico, programaticamente astratto dalla influenza della biografia (subito nel primo capitolo Dahlhaus scrive polemicamente che “”l’immagine di Beethoven che sopravvive nella memoria dei posteri è costituita da un miscuglio di impressioni prodotte dalle opere e di frammenti biografici, i quali constano in gran parte di leggende e di aneddoti””); e tuttavia severamente, strenuamente impegnato a ricostruire il quadro in cui si svolse la carriera artistica e compositiva di Beethoven, a rilevarne e sottolinearne le tappe e l’importanza, a fornircene le possibili interpretazioni tanto nel suo quanto nel nostro tempo. Alla prosa vivace e immediata di Breuning si oppone la compattezza della logica di Dahlhaus, la sua forza argomentativa, la sua densità concettuale. Con Breuning ci si appassiona, si reagisce emotivamente e spesso ci si commuove: è semplice e talvolta ingenuo, tanto da farci apparire Beethoven quasi come uno di noi, solo molto più grande di noi. Del resto, era poco più che un bambino quando conobbe Beethoven, e pubblicò le sue memorie quasi cinquant’anni dopo la sua morte: resistendo però alla tentazione di abbellire, amplificare e infiorare il suo resoconto. Invece per affrontare Dahlhaus occorrono pazienza e caparbietà, e una buona dose di orgoglio. Dahlhaus parla dall’alto della sua scienza invidiabile; ed evidentemente lo fa perché ha un’idea sottile e profonda di Beethoven, e vuol mantenersi all’altezza, per così dire, delle problematiche, in tutti i dettagli e in tutti i momenti del suo ragionamento. Insomma, per Breuning Beethoven era una presenza viva, diretta; per Dahlhaus è un problema aperto da sviscerare, su cui molto si è detto e molto resta ancora da dire, il cui oggetto è rappresentato esclusivamente dalle opere, al più alto grado di complessità.
Presenza o problema? Soggetto od oggetto? Sembra chiaro che per noi Beethoven è l’una e l’altra cosa insieme. E istruttivo, oltre che bello, leggere come il famoso musicista apparisse la prima volta al piccolo Breuning durante una passeggiata pomeridiana, mentre avanzava solitario a passo risoluto: “”un uomo di aspetto robusto, di statura media, energico nel portamento come nei suoi animati movimenti; indossava abiti appena borghesi, privi di eleganza, e tuttavia dalla sua figura emanava un qualcosa di eccezionale””. E le testimonianze di altri, poi, come Grillparzer: “”Beethoven scherzava spesso e volentieri, in un modo che contrastava totalmente con le consuetudini della vita di società. I suoi umori talvolta degeneravano in atteggiamenti sgradevoli, e tuttavia anche in tali circostanze si manifestava in lui un qualcosa di incredibilmente toccante e solenne per cui era impossibile non tenerlo in grande stima e non subire il suo fascino. Solo in un rapporto più intimo Beethoven mostrava il suo lato autentico, e gli amici a lui più vicini avevano costanti prove del suo affetto. Bisogna inoltre aggiungere che la conversazione con lui era generalmente molto faticosa poiché, oltre al fatto di dover sempre scrivere, Beethoven saltava spesso da un argomento all’altro, creando confusione. Per la sua scarsa dimestichezza con la vita di società aveva sempre bisogno di essere circondato da amici a lui assolutamente devoti, ma poteva anche accadere che alcuni cercassero la sua compagnia per interesse””.
Descrizioni come queste – e nelle memorie del Breuning se ne trovano in gran quantità – aiutano molto la comprensione di Beethoven e mettono in moto una serie di collegamenti che possono condurre dall’interpretazione psicologico-biografica fino al centro dello stile personale del compositore, alla sua individualità. Perfino Dahlhaus sembra disposto ad ammetterlo, sia pur parzialmente: “”Al contrario di un radicato pregiudizio degli storici, non è sempre uno svantaggio che si tendesse all’aneddotica perché, per quanto discutibile possa essere la validità dell’aneddoto quale documento empirico biografico, esso può far conoscere l’aspetto sotto cui il soggetto estetico del compositore – che si manifesta nella musica – si presentava ai suoi contemporanei””.
E proprio Dahlhaus a osservare (e per quanto possibile a cercare di dimostrare) che l’immagine che noi abbiamo di Beethoven – il mito del titano, l’ostinato imperativo categorico del “”dover essere””, il “”seid umschlungen Millionen”” e il testamento di Heiligenstadt – si basa su una interpretazione spesso speciosa ed entrinseca, per così dire rimodellata e ammorbidita, dei rapporti di sé assai intricati che intercorrono tra opera e biografia (ossia, nel suo linguaggio, tra “”il soggetto estetico di opere musicali e la persona empirica dell’autore””). Dahlhaus va giù duro su questo punto: “”la semplice affermazione che oggetto della biografia è la persona empirica e nient’ altro sbaglia per difetto. D’altro canto ogni tentativo di desumere dalle opere una `biografia interiore’ corre il rischio di essere una costruzione teorica che, con il pretesto di voler rendere giustizia al soggetto `intelligibile’ che si esprime nell’opera (invece di limitarsi alla persona empirica ricostruibile in base ai documenti), cade nel romanzesco””.
Tornando ai nostri campioni, si potrebbe affermare che mentre il libro di memorie del Breuning si arresta prima di quel limite, il saggio di Dahlhaus lo oltrepassa e, proprio rifiutando il romanzesco (o tutto ciò che a lui pare tale), costruisce la sua interpretazione di Beethoven – smantellando le etichette: classico o romantico, rinnovatore o conservatore, estetica o morale – su una analisi di categorie spinte sempre più in profondità nei labirinti dell’opera: individuandone i percorsi di superficie e sotterranei, ma soprattutto introducendoci in quell’immensa officina delle forme, dei linguaggi e delle conversazioni accettate e distrutte, nella quale si combattè un’aspra lotta per dare espressione a una concezione non solo titanica ma anche metafisica della musica.
L’artista titanico è colui che combatte per conquistare il regno dell’arte, in questo caso della musica; quello metafisico invece si interessa delle ultime e supreme ragioni delle cose: della parte più alta e astratta del pensiero musicale. In questo senso Beethoven fu un artista metafisico. A ciò tendono le sue opere, gradatamente, superando un ostacolo per volta, impadronendosi non di territori nuovi, ma di nuove, essenziali conquiste: per cercare, e alla fine raggiungere, il senso stesso del linguaggio musicale, alle fondamenta e ai vertici. Solo per raggiungere questo scopo, la sostanza stessa dell’espressione e della creazione, dovette essere o sembrare un titano.
Anche l’uomo Beethoven è avvolto in un nimbo metafisico, che si manifesta perfino nelle stravaganze del comportamento e sembra dare ai suoi atti più futili un significato speciale, morale e trascendente, al di là delle cose stesse (Beethoven era trasandato e irascibile fino alla sgradevolezza, ma mai volgare: a differenza di Mozart, non c’era schizofrenia fra il suo comportamento di uomo e di artista). Breuning insiste sul fatto che il suo distacco dal mondo esterno si manifestava talvolta con stranezze veramente fuori dell’ordinario. Così, per esempio, “”non esitava a liberarsi quasi completamente dei suoi vestiti e a portarli poi appesi a un bastone sulla spalla, quando, durante le passeggiate solitarie nei boschi, sentiva troppo opprimente la calura estiva. Si permetteva questo soprattutto nelle boscaglie tra Baden e Gaden, che di preferenza frequentava. Fu a causa di ciò che mio padre espresse ripetutamente il timore che Beethoven potesse aver noie da persone incontrate casualmente””. Ma tutti sapevano che Beethoven non poteva esser giudicato con i criteri che valevano per ogni altra persona. Soprattutto, solo pochi avrebbero osato accostarlo e rivolgergli normalmente la parola. Nella vita di Beethoven così come la possiamo ricostruire dalla fonte del Breuning, per rapidi schizzi, annotazioni ed episodi marginali, si rispecchiano la stessa ansia e la stessa turbolenza che ritroviamo nelle opere, soprattutto in quelle dell’ultimo periodo: solo in forma diversa, a un livello e con contenuti meno elevati e controllati rispetto alla dimensione e alle’prospettive della creazione artistica. Il ritratto dell’uomo Beethoven è il presupposto per capire tendenze, aspirazioni e realizzazioni dell’artista nel e contro il suo tempo: quali Dahlhaus, nel suo ostinato impegno di astrazione da ogni mero riferimento biografico, cerca di precisare. Ma se è vero, come egli afferma, che sarebbe banale e ingenuo trovare corrispondenze dirette tra le due figure, spiegando con vicende della biografia i motivi e i risultati delle opere, è altrettanto vero che in molte descrizioni e riflessioni come quelle di Breuning noi scopriamo la chiave per entrare nella sfera dell’arte: una sfera tanto più sublime e trasfigurata quanto più legata a miserie e grettezze quotidiane – il disfacimento fisico, l’infatuazione ossessiva per il nipote, la sordità e la misantropia – di fronte alle quali, benché ne fosse afflitto, Beethoven non soccombette mai. C’è una vera grandezza in questo Beethoven: tanto più vera e toccante perché non avvolta nella leggenda, consistente di episodi minimi e di disarmanti rivelazioni, ma circonfusa sempre di quella luce metafisica e di quella ricerca dell’indicibile che rendono sfolgoranti le tensioni e gli approdi del lavoro creativo.
Il ponte che collega l””`al di qua”” della biografia – l’insieme di fatti e di documenti da considerare e da interpretare sotto ogni profilo, così come si fa con una pagina di musica – con l’ “”al di là”” dell’opera – che parla un linguaggio cifrato e si muove in un ambito proprio, su un piano più elevato e simbolico – è spesso un ponte invisibile, odi consistenza precaria. Si tende spesso a istituire parallelismi pericolosi e frettolosi, con corsie preferenziali che, anziché abbreviare il cammino, conducono in vicoli ciechi.
Dahlhaus opportunamente mette in guardia dal rischio di vedere nelle opere di Beethoven di preferenza “”frammenti di una grande confessione””. Ma quel percorso che collega biografia e opera non può essere del tutto eluso. Ed è per questo che anche metodi singolarmente antitetici finiscono per essere straordinariamente convergenti nella ricostruzione della personalità di Beethoven: noi la riconosciamo, ambiguamente, nel centro.
Da questo punto di vista non mancano, come i nostri due libri insegnano, coincidenze curiose. Per esempio il concetto di “”subtematica””, che Dahlhaus usa per definire un processo compositivo dell’ultimo Beethoven (un’idea di base, tanto astratta quanto coerente e continua, che istituisce una fitta rete di relazioni latenti, e che si sottrae alle semplici percezioni riflesse in superficie per affondare le sue radici in una complessa “”struttura del profondo””), potrebbe valere anche per racchiudere l’immagine psicologica di Beethoven nei suoi comportamenti e atteggiamenti. E, per usare le parole stesse di Dahlhaus, “”il connotato comune è che la forma non nasce per evoluzione da un enunciato originario, ma consta di parti che appaiono un tutto compiuto in sé se viste retrospettivamente, dalla fine””. Metaforicamente, anche la vita di Beethoven segue il “”ritmo in grande”” che sta alla base della struttura temporale delle sue composizioni, ed è, come queste, un intreccio meravigliosamente fertile di “”cantabilità”” (ossia di poesia: anche la poesia della vita quotidiana, delle sofferenze e delle amarezze) e di inesausto impulso alla elaborazione. A tal punto agisce in essa un’oscura, costante ragione spirituale, un’idea fissa che, al di là dell’apparenza ingannevole di disordine e di penosa contraddizione, muove la sensibilità di Beethoven verso un fine coerente e compiuto, e ce lo fa apparire in una luce diversa, personale.
In modo distinto, ciò che Dahlhaus illustra in un severo lavoro, musicologico e analitico, sulle opere Breuning tratteggia con vividi tocchi e con cordiale candore rappresentativo: senza che alla fine vi sia contraddizione. Non è possibile rinunciare a una delle due parti se vogliamo avvicinarci a Beethoven. Non è possibile rinunciare all’attualità permanente di Beethoven e considerarlo solo un oggetto di analisi o un capitolo grandissimo della storia della musica. Non è possibile rinunciare a trovare le connessioni fra spirito e materia, fra uomo e artista, fra aspetti della biografia ed essenza della musica. Non è possibile rinunciare a emozionarsi e a capire, emozionarsi senza chiedersi perché e credere di capire senza rabbrividire. Ma soprattutto, non è possibile rinunciare a Beethoven.
Musica Viva, n. 5 – anno XIV